Visco: i danni
che ci ha fatto l’Europa
Come lo scorso anno, il governatore nelle Considerazioni finali non risparmia pesanti critiche all’Unione, anche se poi riconferma la sua fede europeista, senza però spiegare che cosa potrebbe cambiare questo modo di procedere. E per l’Italia appoggia la politica – voluta dalla Ue – di alti saldi primari, cioè la politica che finora ha strozzato la nostra crescita
(pubblicato su Repubblica.it il 31 mag 2017)
Potrebbero essere le sue ultime Considerazioni finali quelle che il governatore Ignazio Visco ha letto all’assemblea annuale della Banca d’Italia. Il suo mandato scade infatti tra pochi mesi e una riconferma non è del tutto certa: dipenderà dall’evoluzione della situazione politica, che di certo non appare tranquilla. Un appoggio importante gli è però già venuto da Mario Draghi, che quest’anno ha voluto essere presente: un segnale chiaro da parte del presidente della Bce.
Anche stavolta, come lo scorso anno, la “cifra” più notevole delle Considerazioni è nel nutrito elenco di critiche a vari aspetti della politica europea, che hanno danneggiato non poco il nostro paese. Anche stavolta manca l’indicazione esplicita dei responsabili, che forse non si può pretendere da un organismo tecnico come la Banca d’Italia, ma che per ognuno dei casi ricordati risulta del tutto chiaro a chi abbia seguito le vicende degli ultimi anni: la Germania e i suoi alleati, e la Commissione che alla linea tedesca è del tutto omogenea.
“Dalla fine del 2011 – ricorda il governatore - la politica monetaria assumeva una chiara intonazione espansiva, rafforzava le misure volte a contrastare le gravi carenze di liquidità nel sistema bancario e la conseguente frammentazione dei mercati finanziari. L’esigenza di intervenire per garantire la tenuta della moneta unica si affermava però con fatica in un contesto in cui le tensioni venivano prevalentemente attribuite al deterioramento delle prospettive nazionali di crescita e di finanza pubblica e non anche a un rischio sistemico, quale quello di disgregazione dell’unione monetaria”. Ecco perché il “whatever il takes” di Draghi, che mise fine quasi di colpo alla speculazione sui titoli pubblici, ha tardato tanto: perché “qualcuno” insisteva che bisognava “fare i compiti a casa”, ignorando testardamente e ciecamente che il problema in quel momento era ben altro.
Acquietata la tempesta, a metà del 2013 sarebbe stata “auspicabile la costituzione di una società di gestione degli attivi bancari deteriorati con supporto pubblico, ipotesi che noi abbiamo attivamente sostenuto. La realizzazione dell’intervento è stata tuttavia impedita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato assunti dalla Commissione europea”. Ovvero: ripetuto che all’inizio della crisi le banche italiane avevano un livello di sofferenze non patologico e che lo sarebbe diventato a causa del successivo crollo dell’economia, Visco afferma che l’Italia avrebbe voluto affrontare il problema per tempo, ma le fu impedito. Allora e anche successivamente: “In un contesto di mercato in cui il trasferimento delle attività bancarie è assai difficile, gli interventi preventivi dei fondi di tutela dei depositanti sono stati equiparati dalle autorità europee competenti ad aiuti di Stato, sebbene il loro finanziamento sia interamente di natura privata e il loro utilizzo mosso da scelte imprenditoriali e non da interventi delle autorità. L’impiego di fondi pubblici, pur se conveniente sul piano economico e finanziario, è ora assoggettato a limiti stringenti anche dopo il coinvolgimento di azionisti e detentori di passività subordinate”. Il riferimento è qui al fallimento delle quattro piccole banche (Etruria, Marche, Ferrara, Chieti), alla risoluzione del quale la Commissione ha posto numerosi ostacoli.
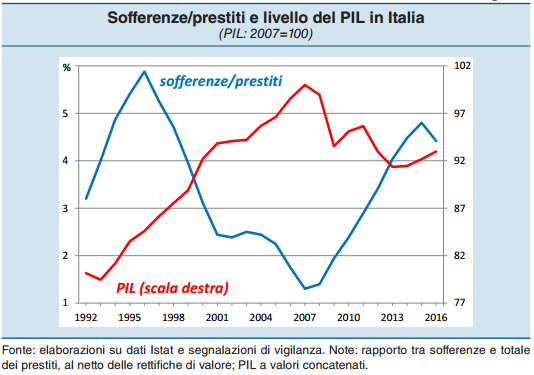
C’è poi il problema dello smaltimento delle sofferenze. Le autorità europee ci mettono fretta, forse anche perché in Italia i tempi di recupero tramite la realizzazione delle garanzie sono più lunghi che negli altri principali paesi: “Alla fine del 2015 la durata effettiva era in media di quasi otto anni per le procedure fallimentari, di oltre quattro per quelle esecutive immobiliari”. Però, “la Vigilanza è consapevole della necessità di non forzare politiche generalizzate di vendita dei crediti deteriorati che conducono, di fatto, a un trasferimento di risorse dalle banche italiane a pochi investitori specializzati”. Qui Visco sembra parlare alla nuora (le banche italiane) perché la suocera intenda (le autorità europee: non costringeteci a svendere questi crediti).
Quanto agli stimoli all’attività economica, chi ha debiti pubblici alti ha spazi limitati, ma dove non sono elevati “è possibile sostenere la domanda interna, in particolare con investimenti in infrastrutture, evitando un livello eccessivo della posizione netta sull’estero, tale da fornire argomenti a sostegno di interventi di protezione commerciale”. Inutile specificare a chi si riferisca, il destinatario è sempre quello.
Non stupisce che il governatore senta il bisogno di ribadire la sue fede europeista. “Anche noi a volte critichiamo regole europee di cui non siamo completamente soddisfatti o scelte di autorità europee che non condividiamo, ma non per mettere in discussione il cammino dell’Europa. Crediamo – e lo abbiamo detto più volte – che uno dei problemi che la crisi ha reso evidente consista proprio nell’incompletezza della costruzione, specie nel campo economico e finanziario. La governance europea del settore si è basata finora quasi solo su regole che, nella ricerca esasperata di garanzie reciproche, vincolano le scelte di ciascun paese. Ne è risultata un’Unione più forte nel proibire che nel fare”. Chi o che cosa farà cambiare la linea seguita finora, Visco non lo dice.
Le ricette per l’Italia non cambiano rispetto a quelle esposte gli scorsi anni. Visco ripete i giudizi positivi sulle riforme del mercato del lavoro, ma sembra ritenere che da quel punto di vista sia stato fatto abbastanza e insiste invece sulla necessità di aumentare gli investimenti, sia pubblici che privati. Quanto alle imprese “in passato si è tentato di far fronte ai mutamenti con la sola riduzione dei costi, in particolare del lavoro”, mentre invece si dovrebbe puntare sull’innovazione, che è il solo modo di far aumentare la produttività stagnante. E quanto alla spesa per gli investimenti pubblici, “in calo dal 2010, la sua incidenza sul prodotto era appena superiore al 2 per cento nel 2016, circa un punto in meno che negli anni precedenti la crisi e tra i valori più bassi nell’area dell’euro. Un aumento delle risorse dedicate alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, non solo pubblico, e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, oltre che al contenimento delle conseguenze di quelli sismici, avrebbe effetti importanti sull’occupazione e sull’attività economica, in misura più accentuata nel Centro Sud”. Ma da dove prendere i soldi necessari? “Restano ampi spazi di razionalizzazione nell’allocazione delle risorse pubbliche che vanno indirizzate verso obiettivi di medio-lungo periodo”.
Che questi “ampi spazi” ci siano davvero viene però da dubitare leggendo i suggerimenti di Visco per la riduzione del debito pubblico. “Con un tasso di crescita annuo intorno all’1 per cento, l’inflazione al 2 e con l’onere medio del debito in graduale risalita verso i valori osservati prima della crisi, un saldo primario (ossia al netto degli interessi) in avanzo del 4 per cento del PIL, sostanzialmente in linea con il quadro programmatico del governo, consentirebbe di ricondurre il rapporto tra debito e prodotto al di sotto del 100 per cento in circa dieci anni. Con una crescita più elevata, conseguibile in un quadro di riforme incisive, di ripresa degli investimenti e con una diversa composizione del bilancio pubblico, i tempi sarebbero più brevi. Già in passato l’Italia ha saputo conseguire e mantenere un alto avanzo primario: tra il 1995 e il 2000 questo è stato in media pari a quasi il 5 per cento del PIL. Altri paesi hanno ottenuto risultati anche migliori e per periodi più lunghi; tra il 1995 e il 2007 l’avanzo primario è stato pari in media a oltre il 6,5 per cento del PIL in Canada, a circa il 5 in Belgio, in Danimarca e in Finlandia. Non è un impegno da poco, ma non è fuori dalla nostra portata”.
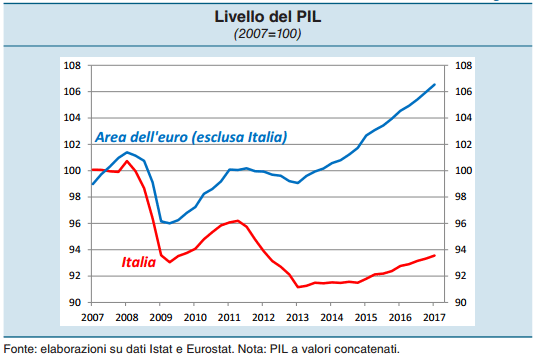
Ora, mantenere un saldo primario positivo del 4% significa attuare una politica di bilancio molto restrittiva. Cioè ammazzare la crescita, a meno di condizioni esterne tanto favorevoli da poterle definire “miracolosamente” favorevoli. Serve una buona crescita del commercio mondiale, prezzi delle materie prime senza impennate, nessuna necessità di attuare sanzioni a paesi importanti per il nostro export (per esempio la Russia: quelle sanzioni care ci sono costate, e ancora ci costano), un cambio che non salga troppo, nessuna “guerra” protezionistica, che la fine del QE non faccia salire troppo i nostri tassi, nessun imprevisto. Forse dimentichiamo qualcosa, ma già questo rende l’idea. Se la politica di bilancio riduce la crescita, che il rapporto con il debito scenda ce lo possiamo scordare: lo stesso Visco, d’altronde, nota che l’aumento di questo rapporto nel corso della crisi è dipesa proprio dall’andamento negativo del Pil.
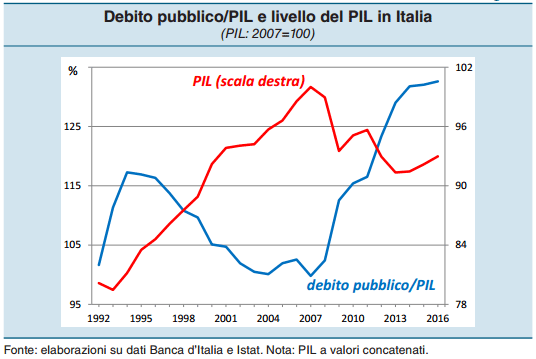
Se questa crisi è stata (ed è) per l’Italia peggiore di quella del ’29, come Visco ha confermato e come si era già detto su queste pagine, bisognerebbe ricordare che allora fu proprio una politica di bilancio troppo restrittiva ad aggravarla, e che se il debito è un problema è solo la crescita che può risolverlo. Visco questo lo sa bene. Il saldo primario di quella dimensione serve solo a restare nei binari delle “stupide” regole europee. Probabilmente resterà solo sulla carta, ma se così non fosse avremmo sacrificato altre migliaia di disoccupati e di persone in difficoltà economica per un periodo ancora più lungo all’idolo dei “conti a posto”, senza nemmeno ottenere, con ogni probabilità, il risultato inseguito.