La produttività ha
il morbo di Baumol
La sua crescita rallenta da decenni in tutti i paesi avanzati, tanto che la si indica come una malattia con il nome dell’economista che per primo ha analizzato il fenomeno. Ma c’entra anche il fatto che le misurazioni lasciano molti dubbi, perché calcolandola per un settore non si considera che parte di essa si genera in altri settori apparentemente meno dinamici
(pubblicato su Repubblica.it il 19 mag 2017)
Nelle lingue ci sono i “falsi amici”, cioè quelle parole che sono quasi uguali a quelle della propria lingua ma che hanno un significato del tutto diverso. Questi “falsi amici” ci sono anche in economia: in molti casi il senso comune inganna, e quello che sembra corretto alla luce della nostra esperienza personale provoca invece effetti negativi se applicato all’economia di un paese. Un classico esempio sono i tagli alla spesa quando le cose vanno male: qualsiasi famiglia si comporta così, e fa bene; in politica economica, invece, è un errore, perché una cosa del genere aggrava la situazione. Ne abbiamo avuto abbondanti prove nel corso di questa crisi, resa infinita proprio dagli errori (sempre che si possano considerare tali) commessi nella sua gestione, seguendo la bizzarra teoria dell’”austerità espansiva”.
Ebbene, forse appartiene a questa “famiglia” anche il principio secondo cui bisogna dare più importanza alla contrattazione aziendale, perché in questo modo ci sarebbe un collegamento più diretto tra l’andamento dei salari e la produttività. La questione è analizzata nel Rapporto sullo Stato sociale, che è stato discusso il 15 maggio alla Sapienza. Da dodici anni il Rapporto, promosso e coordinato da Felice Roberto Pizzuti ma alla cui elaborazione hanno partecipato 27 economisti, è un appuntamento importante per fare il punto sulle situazione del welfare in Italia (confrontata con quella degli altri paesi europei), ma non è ricco solo di statistiche: propone anche analisi originali. Quest’anno è stata dedicata particolare attenzione ai temi della “stagnazione secolare”, della produttività, delle disuguaglianze, del reddito minimo e vari altri (qui l’indice del volume).
Ma torniamo alla produttività, che da anni è in calo in tutte le economie sviluppate (e quindi si intreccia con le tesi sulla “stagnazione secolare”). Gli economisti lo chiamano “morbo di Baumol” dal nome del primo studioso che avanzò una teoria in proposito, addirittura negli anni ’60.
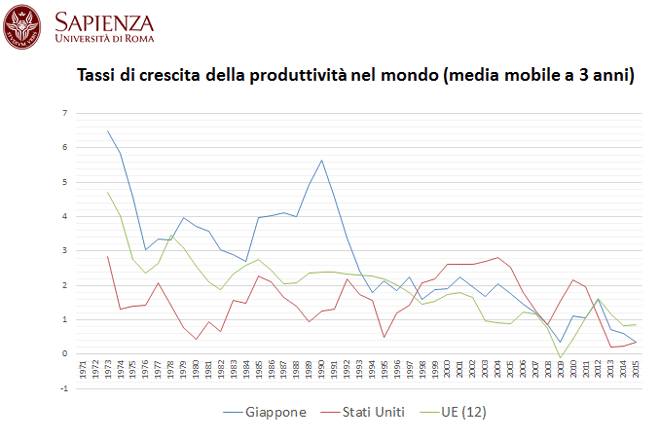
William Baumol mise in evidenza che nelle economie moderne i settori che crescono di più sono quelli in cui la produttività aumenta di meno, ossia i servizi.

Come si vede dai grafici, da allora la tendenza è continuata. Il peso dei servizi – e l’occupazione ad essi relativa – è sempre maggiore sul valore aggiunto, ma la loro produttività, tranne eccezioni, aumenta pochissimo, molto meno di quella della manifattura. Il motivo è una combinazione di un fattore strutturale e un fattore di misurazione. Spiega Pizzuti:
“Le metodologie in uso misurano la dinamica della produttività nei settori dove essa è rilevabile; i quali, tuttavia, non necessariamente sono gli stessi in cui viene generata. Tipico è il caso dell’istruzione, attività nella quale non si registrano aumenti di produttività relativamente elevati (la spiegazione a una classe di studenti del teorema di Pitagora, da circa 2500 anni richiede pressappoco la stessa quantità di tempo); tuttavia, l’offerta e il consumo di quei servizi hanno contribuito agli sviluppi tecnologici da cui sono discesi gli incrementi di produttività emersi in altri settori (sempre negli ultimi due millenni e mezzo, gli elevatissimi incrementi di produttività rilevati nella produzione di chiodi sono dipesi anche dall’insegnamento del teorema di Pitagora)”.
Ci sono dunque “effetti esterni” al settore o all’azienda che certamente esercitano influenza, ma non sono misurabili. Questo fatto, dice ancora Pizzuti, “conferma l’incongruità delle proposte di decentramento contrattuale miranti ad agganciare la dinamica dei salari settoriali e aziendali alle rispettive variazioni della produttività. La loro applicazione non realizzerebbe una distribuzione fondata sul contributo dei lavoratori di ciascun settore o impresa alla crescita della produttività realizzatasi nell’intera economia”.
Naturalmente diamo qui solo un accenno al problema che, nel volume, è trattato in maniera assai più estesa ed analitica. Sta di fatto che pensare di risolvere i problemi della produttività – che, come si vede, hanno cause strutturali di lungo periodo – eliminando o comunque riducendo al minimo la portata dei contratti nazionali a vantaggio di quelli azienda per azienda, appare davvero un’illusione. Anche questa fa parte della teoria economica dominante, che guarda i singoli alberi e perde di vista le necessità della foresta (detto in termini più tecnici, si concentra sulla microeconomia e si rifiuta di considerare i problemi dal punto di vista macroeconomico). Salvo poi stupirsi se le ricette non funzionano, rifugiandosi nell’alibi che servono dosi più massicce della stessa medicina.